La simbiosi uomo – macchina va governata esercitando il pensiero critico. Intervista VIP a Gian Maria Fara.
La sfida di oggi è trasformare l’accesso al digitale in una strategia di crescita. Il sistema Italia dovrà investire prima di tutto in educazione e in competenze per poter reggere i ritmi del cambiamento. Il salto quantico, di cui parla il Presidente Fara nell’intervista, non riguarda solo i traguardi pur eccezionali della tecno-scienza, perché si è aperta una sfida cognitiva, simbolica, relazionale che dobbiamo prepararci ad affrontare per abitare con consapevolezza la complessità e tornare ad esercitare una cittadinanza attiva e responsabile.
“Il Rapporto delle persone con il digitale” curato dall’Eurispes analizza un tratto distintivo della contemporaneità. Presidente Fara, che cosa emerge nella vostra indagine?
L’individuo di oggi vive il digitale in una dimensione omeopatica. Non riusciamo a farne a meno, fa parte di noi. Il virtuale, come ha scritto in un celebre saggio che ha anticipato i tempi, il filosofo francese Pierre Levy è una categoria dell’essere. C’è un fattore cruciale che va considerato per capire come si è evoluto il nostro rapporto con gli strumenti hi-tech. Mi riferisco allo spartiacque che separa le generazioni prima del Duemila che hanno vissuto in spazi fisici, geometricamente delimitati e definibili e i nati nel terzo millennio, che fin dai primi vagiti si sono mossi in ambienti interconnessi, “ibridi”, in cui non è possibile distinguere tra reale e virtuale.
Lo scarto che esiste tra questi universi non è solo tecnologico, ma cognitivo, simbolico, relazionale. È cambiata la natura stessa del rapporto uomo – macchina, la simbiosi che stiamo sperimentando nell’uso di strumenti come lo smartphone ha modificato la percezione della nostra identità rispetto alla fluidità dell’ecosistema in cui si matura la nostra personalità e ruolo sociale.
Le conseguenze di quella che appare come una profonda mutazione antropologica hanno spinto molti pensatori a parlare di “fine dell’umano”. Stiamo correndo realmente questo rischio?
L’approccio all’analisi del cambiamento deve seguire un metodo razionale, senza cedere a tentazioni di tipo assolutistico. Nel divenire che investe tutti, il valore dell’educazione deve rimanere un punto centrale, se vogliamo attuare una digitalizzazione rispettosa dell’uomo e dei principi di solidarietà ed equità. Il prepotente sviluppo della tecnoscienza, negli ultimi venti anni, non è stato accompagnato da una crescita culturale, educativa, etica e istituzionale all’altezza della complessità del tempo presente.
Le tecnologie hanno mutato il nostro rapporto con il tempo, con la costruzione dell’identità, stanno alterando le dinamiche interpersonali e i processi sociali, dobbiamo imparare ad affrontare con consapevolezza queste trasformazioni per non subirle. Le generazioni analogiche vedevano il tempo in modo sequenziale, narrativo, riflessivo; le “generazioni del pollice” vivono una dimensione esistenziale frammentata, veloce, orientata in modo estremo alla performante.
Non potrebbe essere altrimenti se, come ci dicono i dati dell’Atlante dell’infanzia a rischio, l’età di accesso allo smartphone continua ad abbassarsi: già i bambini tra sei e dieci anni che ne fanno uso sono più del 30%. Sarà dunque necessario lavorare fin dai primi anni di scuola sui linguaggi del digitale, che hanno una precisa sintassi che bisogna conoscere a fondo per poterli padroneggiare, per ridurre le paure diffuse e, nel contempo, aumentare la fiducia e il senso di sicurezza oggi messo sotto scacco dal potere crescente da usi distorti delle tecnologie come fa il cyber crimine.
Nel delicato ambito delle relazioni sociali si registrano criticità che meritano attenzione. Possiamo cercare di tratteggiarle in sintesi?
 Vi sono vulnerabilità cognitive, psicologiche, che oltre ad avere dei riflessi sulla sfera dell’io, hanno delle ricadute sulla coesione sociale e persino, come si sta vedendo molto bene sul terreno della geopolitica, sulla stabilità dei sistemi democratici. L’informazione on line continua, che genera una sorta di esaurimento che si manifesta con ansia, sensazione di sopraffazione e una diminuzione della sensazione di benessere è un caso emblematico. Gli esperti parlano di burnout cognitivo, dettato da una saturazione che non innalza il nostro livello di conoscenza dei fatti e degli eventi; al contrario, porta a una distrazione sistematica, fino all’incapacità di sviluppare quel pensiero critico, che è necessario alimento della vita democratica.
Vi sono vulnerabilità cognitive, psicologiche, che oltre ad avere dei riflessi sulla sfera dell’io, hanno delle ricadute sulla coesione sociale e persino, come si sta vedendo molto bene sul terreno della geopolitica, sulla stabilità dei sistemi democratici. L’informazione on line continua, che genera una sorta di esaurimento che si manifesta con ansia, sensazione di sopraffazione e una diminuzione della sensazione di benessere è un caso emblematico. Gli esperti parlano di burnout cognitivo, dettato da una saturazione che non innalza il nostro livello di conoscenza dei fatti e degli eventi; al contrario, porta a una distrazione sistematica, fino all’incapacità di sviluppare quel pensiero critico, che è necessario alimento della vita democratica.
Il nostro cervello si sta appiattendo sui tempi di reazione di un tweet o su un reel di Instagram, che smorza l’ampiezza del ragionamento e la capacità di progetto del singolo. FOMO (acronimo che sta per Fear of Missing Out n.d.r.) è un altro fenomeno emergente, nasce dalla percezione amplificata dai social network, attraversati dagli innumerevoli eventi e opportunità cui tutti partecipiamo. Stories, post in scadenza, notifiche creano un bisogno costante di presenza, di vigilanza. In Italia l’impatto di questa fenomenologia è particolarmente forte se consideriamo che oltre il 70% dei giovani tra i 14 e i 19 anni prova forme di ansia legate alla necessità di rimanere esposti in una sorta di “vetrina digitale”, che genera dipendenza, espone al rischio, imprigiona in “camere dell’eco” autoreferenziali, dove ascoltiamo e leggiamo solo chi la pensa come noi, con il risultato di un restringimento dell’orizzonte conoscitivo che soffoca il livello di consapevolezza individuale.
La rivoluzione dell’IA
L’irruzione dell’IA nella complessa dinamica di rapporti tra uomo-macchina che sta descrivendo, che cosa ha comportato?
Un “salto quantico” e una potente accelerazione dei fattori di trasformazione delle reti sociali e del sistema produttivo. Il termine “opacità algoritmica” è quello che fotografa meglio l’incapacità da parte degli utenti di comprendere appieno i meccanismi di funzionamento che portano l’IA ad assumere decisioni e comportamenti. In molti casi, specialmente con l’uso di machine learning (apprendimento automatico n.d.r) e del deep learning (reti neurali complesse che studiano i meccanismi cerebrali), le logiche interne rimangono incomprensibili persino agli stessi sviluppatori. L’ultima rilevazione dell’Eurispes, pubblicata nel Rapporto Italia 2025, mette in evidenza un atteggiamento verso l’IA che potremmo definire prudente: solo il 20% degli italiani la considera un’opportunità, appena il 7% la vede come una soluzione a moltissimi problemi.
Luci e ombre prevalgono, infatti, tra le persone sollecitate dall’indagine: emerge una richiesta di controllo del prepotente sviluppo dell’IA, che si innesta in una visione in generale critica. La frattura generazionale, cui facevo prima riferimento, appare qui in maniera netta: tra i 18-24enni, il 44% considera l’IA una opportunità, il 16% una soluzione, mentre tra gli over 64 solo il 10% è favorevole, prevale la paura e l’incertezza. Due universi che non comunicano, che invece sarebbe importante far dialogare perché potrebbero insieme costituire un antidoto importante a quella che molti studiosi definiscono “alienazione tecnologica”. Per arginare la deriva si sta sperimentando il digital detox, come pratica di limitazione e di spazi di disconnessione che sta prendendo piede in Europa: è la nuova frontiera della salute pubblica e del benessere che guadagnerà molta attenzione in futuro.
 Le fragilità e le paure con cui milioni di utenti hanno a che fare investono sempre più i modelli di convivenza e la vita collettiva delle città. Quali scenari si stanno aprendo?
Le fragilità e le paure con cui milioni di utenti hanno a che fare investono sempre più i modelli di convivenza e la vita collettiva delle città. Quali scenari si stanno aprendo?
La trasformazione digitale sta modificando tutte le strutture che governano la vita collettiva. Basti considerare quello che sta avvenendo riguardo alla qualità del dibattito pubblico, alla coesione sociale, alla difficoltà del sistema educativo di adattarsi ai cambiamenti. Quest’ultimo aspetto ha dei riflessi importanti sulla possibilità di attuazione del Programma per il Decennio Digitale dell’UE. Va ricordato che solo il 46% degli italiani tra i 16 e i 74 anni possiede competenze digitali, un dato molto inferiore alla media europea (54%) ben lontano dall’obiettivo fissato dalla Commissione UE (80%). La percentuale scende sotto il 30% tra la popolazione over 60 con picchi di marginalità nelle aree rurali e del Mezzogiorno.
Bisogna inoltre tenere conto che entro il 2030 avremo bisogno di almeno 20 milioni di specialisti nel settore ICT per sostenere lo sviluppo nei settori più innovativi. Siamo ancora fermi a circa 9 milioni: l’offerta formativa non riesce a stare al passo con l’evoluzione delle tecnologie. A questo si aggiunge la rappresentanza di genere nelle professioni digitali: oggi, in Europa, meno di 2 degli specialisti ICT su 10 sono donne. La rimozione di ogni barriera culturale, il rafforzamento delle competenze nelle aree STEM sarà decisivo perché segnerà un reale crescita della cittadinanza digitale, scandendo un miglioramento delle performance delle nostre imprese.
Il ruolo delle PMI
Quello che ha toccato è un nodo strategico. Le PMI nella rivoluzione in atto che posto occuperanno?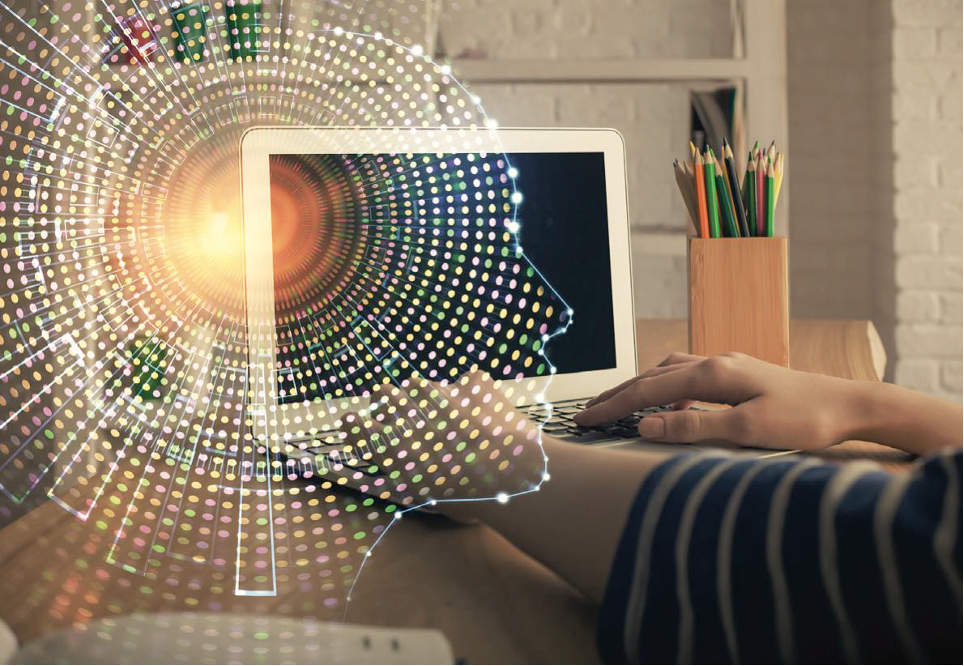
Sono destinate a rimanere il perno del nostro sistema produttivo. Non mancano anche su questo fronte delle debolezze strutturali da colmare. Secondo Eurobarometro 2025, solo il 58% delle PMI italiane ha raggiunto un livello base di intensità digitale, rispetto al 69% della media Ue. Il divario non riguarda solo il numero di imprese digitalizzate, ma anche la qualità e la maturità delle tecnologie adottate. Solo il 6% delle aziende italiane utilizza l’intelligenza artificiale, rispetto al 10% della media Ue, mentre il cloud computing è adottato dal 22% delle imprese italiane, contro una media Ue del 34%.
Quali sono i maggiori ostacoli che non consentono di compiere il salto necessario?
La mancanza di competenze digitali interne; la scarsa disponibilità di consulenza; la difficoltà di accesso al credito e agli incentivi pubblici in forma semplificata; modelli gestionali poco innovativi. Il divario territoriale continua a essere significativo: nelle regioni del Nord, le imprese mostrano un livello medio di digitalizzazione superiore rispetto a quelle del Centro- Sud.
Guardando ai vari settori, le imprese manifatturiere risultano mediamente più digitalizzate rispetto a quelle dei servizi tradizionali, mentre le filiere agroalimentari, turistiche e artigianali, in generale, sono meno digitalizzate. Vi sono, e non vanno sottaciuti, alcuni segnali positivi che vengono dal nostro contesto: nel triennio 2020–2023, grazie agli incentivi del Piano Transizione 4.0, si è registrato un aumento del 12% negli investimenti digitali nel manifatturiero. Da questo dato credo si debba ripartire, per avviare il percorso di una crescita effettiva di sistema.
Autore: Massimiliano Cannata




