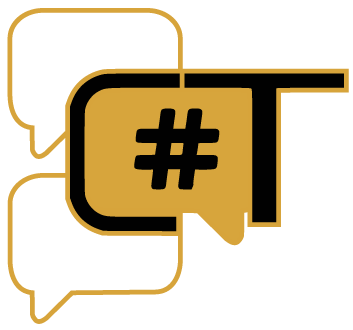Perché le competenze cognitive sono il nuovo perimetro della sicurezza informatica
Nel panorama della cybersecurity, dove ogni giorno emergono nuove vulnerabilità tecniche, il rischio più subdolo resta quello legato al comportamento umano. Human Risk Management, psicologia del comportamento e Direttiva NIS2. La Direttiva NIS2, approvata dall’Unione Europea nel 2022, ne prende atto in modo esplicito, ponendo l’attenzione sulla gestione dei rischi “di natura tecnica, operativa e umana”. È qui che il concetto di Human Risk Management (HRM) incontra la psicologia comportamentale, offrendo alle organizzazioni un nuovo paradigma per costruire una cultura della sicurezza realmente efficace.
L’anello debole è prevedibile: comprendere l’errore umano
Nel lessico della sicurezza informatica, il “fattore umano” è spesso descritto come ”l’anello debole della catena”. Ma l’errore umano non è un evento casuale o sfortunato. È, molto più spesso, il risultato prevedibile di bias cognitivi, sovraccarico decisionale, automatismi e pressioni ambientali. In altre parole: non si tratta di ignoranza o disattenzione, ma di meccanismi psicologici naturali che, se ignorati, possono rendere inefficaci anche le difese tecnologiche più avanzate. Un esempio emblematico è il phishing: anche dipendenti ben formati possono cliccare su link dannosi in condizioni di stress, urgenza o multitasking. Il problema non è la mancanza di conoscenze, ma l’incapacità del contesto lavorativo di supportare decisioni sicure in tempo reale.
La Direttiva NIS2: un cambio di paradigma anche per la formazione
La Direttiva NIS2 (Direttiva UE 2022/2555) impone agli Stati membri e alle organizzazioni “essenziali” e “importanti” nuovi obblighi in termini di governance del rischio. L’articolo 21, in particolare, richiede che le entità adottino misure tecniche, operative e organizzative adeguate alla gestione dei rischi, “inclusi quelli relativi al fattore umano”. Non è più sufficiente “fare formazione una tantum”: la NIS2 apre la strada a un modello più maturo di gestione del rischio, che include la valutazione dei comportamenti, la modifica degli schemi decisionali e l’integrazione del fattore umano nei processi di sicurezza.
Human Risk Management: dalla formazione alla trasformazione comportamentale
Il concetto di Human Risk Management si fonda sull’idea che la sicurezza informatica non sia solo una questione tecnologica, ma un fenomeno sociocognitivo. Non basta trasmettere nozioni; occorre trasformare abitudini, atteggiamenti, automatismi. E per farlo, serve un approccio mutuato dalle scienze comportamentali.
A differenza della formazione tradizionale, spesso teorica e poco memorabile, l’HRM si concentra su:
- analisi comportamentale dei rischi umani (es. risposta a phishing simulati, uso scorretto di dati e password);
- interventi basati su principi psicologici, come il nudging, il rinforzo positivo, la ripetizione distribuita e il contesto decisionale;
- personalizzazione dei contenuti in base a ruolo, rischio e stile cognitivo dell’utente;
- integrazione tra security awareness, cultura aziendale e processi decisionali quotidiani.
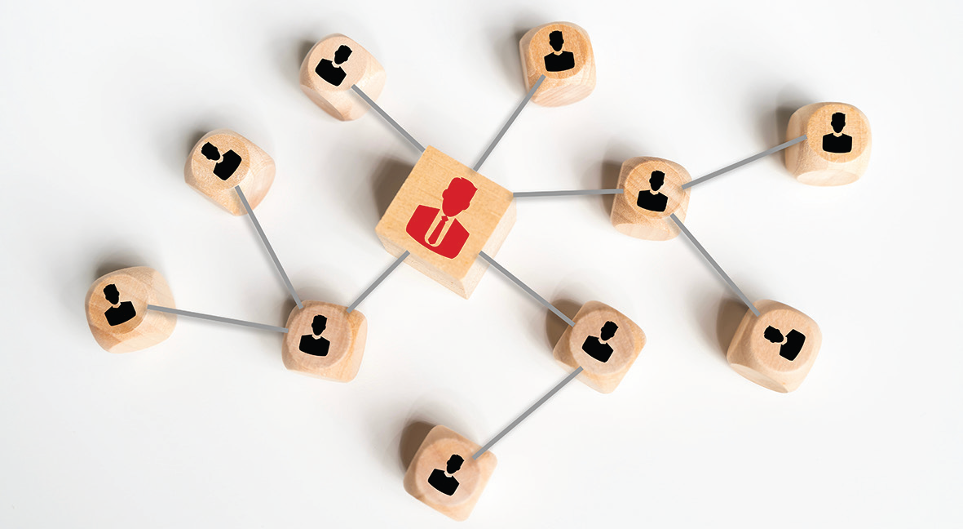
Psicologia comportamentale e sicurezza: una nuova alleanza
Le scienze comportamentali offrono strumenti preziosi per ridurre il rischio umano.
Alcuni concetti chiave:
- Bias cognitivi: errori sistematici nel giudizio (es. effetto di familiarità, overconfidence) possono portare l’utente a sottovalutare segnali di pericolo.
- Effetto framing: la modalità con cui viene presentata un’informazione ne modifica la percezione (es. un alert “urgente” attiva risposte impulsive).
- Nudging: piccoli interventi che, senza imporre, “spingono dolcemente” verso scelte più sicure (es. impostazioni predefinite sicure, notifiche contestuali).
- Habituation e memoria implicita: contenuti ripetuti con varietà aumentano la memorizzazione rispetto a una singola sessione intensiva.
Integrare questi elementi nei percorsi di HRM significa passare da un approccio “comunicativo” a uno trasformativo.
Oltre il training: come misurare il rischio umano
Uno dei limiti storici della formazione alla sicurezza è la scarsa misurabilità. L’HRM propone invece una logica data-driven, dove il rischio umano diventa quantificabile attraverso indicatori specifici:
- behavioral Risk Score individuale o di gruppo;
- tassi di risposta a campagne simulate#(es. clic su phishing);
- livello di engagement nei contenuti formativi; 4prontezza nella risposta a incidenti simulati;
- miglioramento progressivo nel tempo (riduzione dell’esposizione comportamentale).
Questi dati, aggregati e anonimizzati, consentono di costruire una mappa dinamica del rischio umano all’interno dell’organizzazione, utile sia per azioni correttive mirate sia per finalità di audit e conformità.
La sicurezza come comportamento collettivo
Uno degli aspetti più innovativi dell’approccio HRM è l’idea che la sicurezza sia un comportamento collettivo, non solo individuale. Cultura, leadership, comunicazione interna, ambienti digitali e pratiche di lavoro influenzano profondamente la sicurezza quotidiana.
Promuovere la cultura della sicurezza significa:
- coinvolgere tutti i livelli aziendali, dal top management ai neoassunti;
- integrare la sicurezza nei processi di onboarding, change management e gestione del personale;
- valorizzare le reti informali, i modelli di ruolo interni e il feedback continuo.
Solo così si costruisce un contesto in cui comportarsi in modo sicuro diventa la norma, non l’eccezione.

Conclusione: un’opportunità culturale e normativa
La NIS2 non rappresenta solo un obbligo regolatorio, ma l’opportunità per ripensare il ruolo delle persone nella sicurezza informatica. L’Human Risk Management, fondato sulla psicologia comportamentale, offre gli strumenti per costruire non solo utenti “formati”, ma persone capaci di agire responsabilmente in un contesto digitale complesso. In un mondo dove il rischio non è più solo tecnologico ma umano-comportamentale, il vero perimetro della sicurezza è nella mente di chi ogni giorno prende decisioni. E il futuro della cybersecurity passa – inevitabilmente – dalla capacità di comprenderla, misurarla e trasformarla.
Autore: Veronica Patron