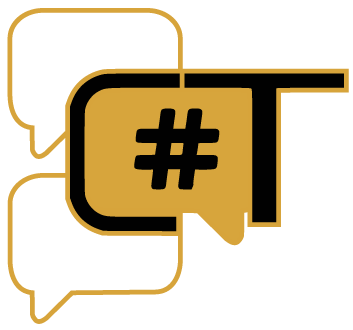LA FINE DEL “SOGNO” DI INTERNET
Intervista VIP a Padre Paolo Benanti
Nell’era del sintetico dobbiamo restare umani. Internet è stata una grande illusione di libertà che rischia di implodere. La pandemia ci ha detto che abbiamo trasformato molti processi analogici in digitale, questo ha spostato il locus of control. Domina oggi un potere computazionale, in mano a pochissimi soggetti. Padre Benanti consigliere del Papa ed esperto dell’ONU è divenuto un ambasciatore dei valori dell’umanesimo integrale in una società che sembra aver affidato tutto al potere infinitesimale dell’algoritmo. Nel suo ultimo saggio Il crollo di Babele (ed. San Paolo) si può trovare la summa di un pensiero forte, che tematizza le grandi questioni legate allo sviluppo della tecnoscienza, senza pregiudizi, con razionale consapevolezza.
Padre Benanti dopo la “Rivoluzione Internet” siamo già alla restaurazione? Cosa sta avvenendo?
Che già a partire dalla seconda decade del 2000 il vento è cambiato. La crescita delle grandi piattaforme che governano il web, la necessità di monetizzare i dati degli utenti, il nuovo “petrolio” che fa gola ai “signori della Rete”, il proliferare delle fake news, hanno generato una nuova “Babele” di incomprensioni, equivoci, solitudini togliendo di fatto agli utenti quella libertà che dovrebbe sostanziare un mezzo straordinario, quale è Internet. Comanda chi possiede i server. Il 70% è di proprietà di due compagnie di Seattle, il 100% di sole cinque compagnie al mondo. Un poter immenso a disposizione di pochi. Quanto è avvenuto nel 2021 negli USA con le rivolte di Capitol Hill e l’assalto al Campidoglio ha svelato il potere delle piattaforme digitali capaci di mobilitare le masse e di trasformare la disinformazione on line in azioni reali, drammaticamente violente. Sono eventi fissati nella nostra memoria che sollevano interrogativi etici e giuridici sulla censura e sulla regolamentazione dei contenuti in rete, rimasti in larga parte insoluti.
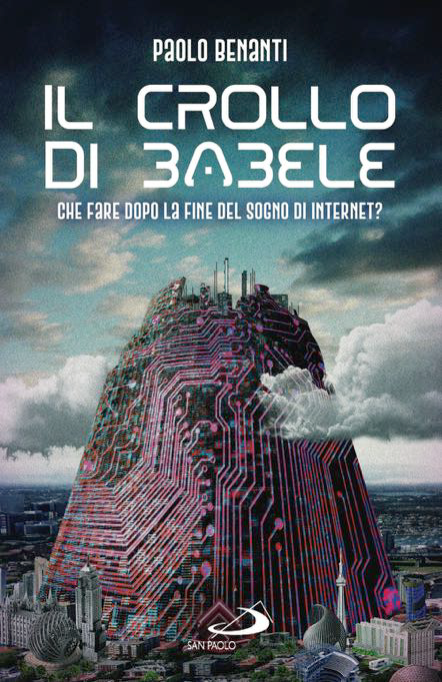
Lei usa l’immagine della Torre di Babele, che l’umanità vive come castigo. Non Le pare eccessivamente negativa questa visione?Il racconto di Babele è divenuto nei secoli emblematico della nostra cultura. La costruzione della torre evoca il sogno dell’umanità di trovare un’unica lingua, un canale universale di scambio e di intesa per tessere relazioni e creare un’alleanza tra popoli di diverse etnie e culture. Internet ha espresso, soprattutto nel primo decennio di questo millennio, lo stesso desiderio di costruzione di una piazza universale, che è storicamente culminata con le Primavere arabe del 2011, che ci avevano fatto credere che gli strumenti digitali fossero adatti a unire anche le realtà geograficamente più lontane. In realtà questo non è avvenuto, ci siamo esposti al rischio che le macchine decidano per noi, pensando che l’algoritmo fosse la soluzione.
Ho portato un esempio in un recente colloquio con Walter Veltroni pubblicato dal Corsera, quello di aver chiesto all’intelligenza artificiale: “Come faccio a eliminare il cancro dalla faccia della terra?” La risposta è stata: “Eliminando tutti gli uomini”. Evidentemente qualche cosa non funziona, i processi di argomentazione e riflessione dell’uomo non possono essere demandati a questa forma particolare di “sapiens” telematico, che abbiamo messo al mondo.
Dobbiamo definire meglio le regole per lo sviluppo di strumenti straordinari come il sistema di intelligenza artificiale generativa?
L’Europa lo sta facendo, bisogna andare avanti su questa strada. La nostra civiltà possiede gli enzimi che provengono da una radicata cultura del diritto. Esiste l’associazionismo, gli enti intermedi, certo non basta, servirebbe una sorta di brain helmet un caschetto che aiuti a difenderci dal pensare oltre.
Si fa strada una nuova età dei diritti
Appare evidente che siamo di fronte a un “salto quantico” che vede sempre più alleate tecnologia e potere. La rielezione di Trump, che ha messo in campo equilibri e dinamiche nuovi, basti pensare al ruolo di Elon Musk, si può considerare come la fotografia di un profondo cambiamento d’epoca?
Elon Musk, psicopolitica e potere digitale costituiscono il trinomio che ha scandito il crollo del sogno di Internet e l’avvento di una nuova era guidata dall’intelligenza artificiale. Capitol Hill ha manifestato il primo alert sul futuro della democrazia nello spazio digitale computazionale. La diffusione dello smartphone ha fatto sì che ognuno di noi si ritrovasse in tasca un potere, mai avuto prima. Questo di fatto ci ha tolto autonomia, perché da quel momento la tecnologia che alberga dentro di noi, si interpone tra il soggetto e le cose condizionando le nostre conoscenze e relazioni.
La digitalizzazione del quotidiano non avrebbe dovuto rendere la vita più semplice?
Il digitale è uno strumento ambivalente. Pensiamo a quello che i social ci hanno consentito di fare abbattendo le barriere spazio-temporali, facilitando la condivisione di informazioni, opinioni e la creazioni di vere e proprie “comunità” di interessi. Ma non scordiamoci che i server sono anche imprese che coprono costi di esercizio e ingenerano guadagni grazie alla like economy, che prevede la monetizzazione dei contatti degli utenti. È evidente che tutto questo ha stravolto il profilo originale dell’utopia, che concepiva la Rete come l’agorà di uno scambio disinteressato tra soggetti liberi di agire e di pensare. Social network e tecnocrazia in una espansione incontrollata stanno invece schiacciando l’individuo. È questo il terreno di sfida, su cui si ruota il futuro di tutti.
“Noi e la macchina” verso la sostenibilità digitale
Intanto il prepotente sviluppo della tecnoscienza e la diffusione delle piattaforme digitali stanno modificando i linguaggi della democrazia. Quali sono i rischi cui andiamo incontro?
I rischi li stiamo già vedendo. Si sta affermando una plutocrazia delle piattaforme che agisce sui governi condizionandone le scelte. L’America, come è spesso accaduto nella storia, fa da apripista su determinati fenomeni, che appaiono destinati a replicarsi in altre aree del Pianeta. Dobbiamo pensare che la nostra stessa esistenza e capacità di agire sono state ormai riconfigurate in forma digitale, ne discende che anche il nostro diritto e potere di cittadinanza è divenuto computazionale. L’IA con il suo prepotente impatto si è aggiunta, complicando il quadro.
A cosa si riferisce, può spiegarcelo meglio?
Alle applicazioni dell’intelligenza generativa che sfumano la linea di demarcazione tra il potere computazionale personale e il potere centralizzato del cloud, la “nuvola” che contiene informazioni e dati sensibili che ci riguardano. Questa centralizzazione ha a che fare con la democrazia e il bilanciamento dei poteri su cui si basa. Per intenderci: stiamo correndo il rischio che si formi una oligarchia del cloud che può far collassare la democrazia.

I politologi parlano a proposito di tech right cercando di dare un nome all’ideologia emergente, nata nella Silicon Valley, che si fonda sulla stretta alleanza tra conservatorismo politico e potere tecnologico. Qual è il suo giudizio in merito?
Non entro nelle valutazioni politiche che esulano dal mio studio. Una cosa è certa: attualmente è in corso una guerra cognitiva che si svolgen el cyberspazio, che include anche i media tradizionali e la tv destinata a modificare gli equilibri geopolitici. La guerra in Ucraina combattuta con armi non convenzionali basata su strategie militari sulla manipolazione delle percezioni e delle decisioni del nemico attraverso l’uso delle tecnologie digitali è la dolorosa prova che sono cambiate le regole nel gioco del potere. Questo non può che avere riflessi sulla salute della democrazia.
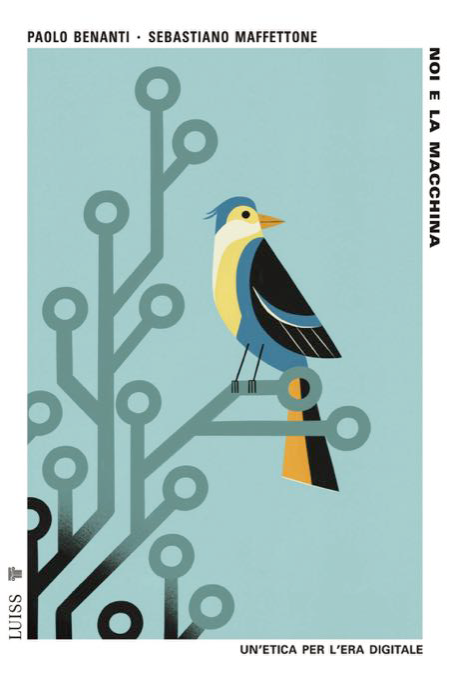
Tra le contromisure possibili alla deriva del potere schiacciante dei colossi del web, Lei insieme al filosofo della politica Sebastiano Maffettone individua nel saggio “Noi e la macchina” (Luiss University Press) il possibile percorso di una “sostenibilità digitale”. Di che cosa si tratta?
Di mettere dei paletti normativi, etici e giuridici per istruire correttamente la macchina, L’algoretica è la disciplina che impone dei guardrail proprio come avviene con le automobili perché non sbandino. Di certo nessuno può dire come vivremo in questi anni Trenta del secolo e cosa lasceremo alle generazioni future dopo il crollo della Babele digitale. Una cosa, in ultimo, appare evidente: lo scenario analogico-digitale di una contemporaneità segnata dalla post verità, dalle fake news, attraversata da complottismi e populismi di diversa estrazione, impone, di fronte allo strapotere degli attori digitali, la collaborazione tra pubblico e privato, quale strumento necessario per rafforzare le difese collettive contro le minacce cyber che stanno mettendo in ginocchio la democrazia a tutte le latitudini e con essa i più elementari principi dello stato di diritto. Le classi dirigenti farebbero bene a tenerlo bene a mente.